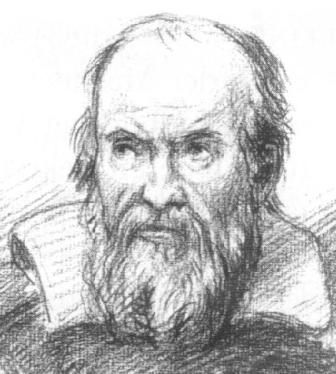 Tra qualche giorno ci sarà la beatificazione di Giovanni Paolo II. Perché ce ne occupiamo in un blog sulla didattica delle scienze? Come indica il titolo, per le sue posizioni sul “caso” Galileo. Molte vicende di Galileo sono note. Sinteticamente possiamo dire che, con le sue opere e le sue idee favorevoli al “Sistema copernicano” e alla teoria eliocentrica, condusse una difficile battaglia per l’autonomia e la libertà della scienza. Sosteneva che come la Bibbia deriva da Dio ed è alla base della religione cristiana, allo stesso modo, anche la natura deriva da Dio ed è alla base della scienza. In particolare, la scienza si occupa dello studio e dell’interpretazione dei fenomeni naturali che sono scritti con un linguaggio prevalentemente matematico. La religione invece si occupa dell’etica, dei comportamenti, dell’anima e della vita ultraterrena. Scienza e fede pertanto non debbono essere in contrapposizione ma ciascuna è autonoma nel proprio ambito. Un’altra dura lotta di Galilei venne portata avanti contro il dogmatismo degli aristotelici che, secondo lui, inebetisce gli intelletti. I suoi studi sulla fisica, riguardanti il principio di inerzia, le leggi sulla caduta dei gravi e il secondo principio della dinamica, furono notevoli. Non meno importanti furono le scoperte astronomiche dovute all’uso del telescopio e il suo “Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo” in difesa del copernicanesimo. L’altro grande merito di Galilei è stato il metodo d’indagine scientifico o metodo sperimentale. Questo metodo detto anche “galileiano” è basato su aspetti analitici (osservazione dei fenomeni, misurazione matematica dei dati, formulazione di ipotesi ad essi correlate) e su momenti di sintesi (verifica sperimentale delle ipotesi, formulazione di eventuali leggi). Questo modo di affrontare i fenomeni fisici e naturali ci consente di definirlo “Padre della scienza moderna”. Le sue idee, soprattutto quelle a sostegno della teoria di Copernico gli costarono, da parte della Chiesa, l’ammonizione, la condanna e l’umiliazione dell’abiura in ginocchio davanti ai cardinali della Congregazione del Sant’Uffizio. Per quasi 400 anni la posizione della Chiesa nei suoi confronti non è cambiata di molto. Cosa ha fatto Giovanni Paolo II? Innanzitutto il 10 novembre 1979, in un discorso alla Pontificia Accademia delle Scienze dice: “Signor Presidente! Ella nel Suo discorso ha detto giustamente che Galileo e Einstein hanno caratterizzato un’epoca. La grandezza di Galileo è a tutti nota, come quella di Einstein; ma a differenza di questi che oggi onoriamo di fronte al Collegio cardinalizio nel nostro palazzo apostolico, il primo ebbe molto a soffrire – non possiamo nasconderlo – da parte di uomini e organismi di Chiesa. Il Concilio Vaticano II ha riconosciuto e deplorato certi indebiti interventi: “Ci sia concesso di deplorare – è scritto al n. 36 della Costituzione conciliare Gaudium et spes – certi atteggiamenti mentali, che talvolta non mancarono nemmeno tra i cristiani, derivati dal non avere sufficientemente percepito la legittima autonomia della scienza, e che, suscitando contese e controversie, trascinarono molti spiriti a tal punto da ritenere che scienza e fede si oppongano tra loro;. Il riferimento a Galileo è reso esplicito dalla nota aggiunta, che cita il volume Vita e opere di Galileo Galilei di Mons. Paschini, edito dalla Pontificia Accademia delle Scienze.
Tra qualche giorno ci sarà la beatificazione di Giovanni Paolo II. Perché ce ne occupiamo in un blog sulla didattica delle scienze? Come indica il titolo, per le sue posizioni sul “caso” Galileo. Molte vicende di Galileo sono note. Sinteticamente possiamo dire che, con le sue opere e le sue idee favorevoli al “Sistema copernicano” e alla teoria eliocentrica, condusse una difficile battaglia per l’autonomia e la libertà della scienza. Sosteneva che come la Bibbia deriva da Dio ed è alla base della religione cristiana, allo stesso modo, anche la natura deriva da Dio ed è alla base della scienza. In particolare, la scienza si occupa dello studio e dell’interpretazione dei fenomeni naturali che sono scritti con un linguaggio prevalentemente matematico. La religione invece si occupa dell’etica, dei comportamenti, dell’anima e della vita ultraterrena. Scienza e fede pertanto non debbono essere in contrapposizione ma ciascuna è autonoma nel proprio ambito. Un’altra dura lotta di Galilei venne portata avanti contro il dogmatismo degli aristotelici che, secondo lui, inebetisce gli intelletti. I suoi studi sulla fisica, riguardanti il principio di inerzia, le leggi sulla caduta dei gravi e il secondo principio della dinamica, furono notevoli. Non meno importanti furono le scoperte astronomiche dovute all’uso del telescopio e il suo “Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo” in difesa del copernicanesimo. L’altro grande merito di Galilei è stato il metodo d’indagine scientifico o metodo sperimentale. Questo metodo detto anche “galileiano” è basato su aspetti analitici (osservazione dei fenomeni, misurazione matematica dei dati, formulazione di ipotesi ad essi correlate) e su momenti di sintesi (verifica sperimentale delle ipotesi, formulazione di eventuali leggi). Questo modo di affrontare i fenomeni fisici e naturali ci consente di definirlo “Padre della scienza moderna”. Le sue idee, soprattutto quelle a sostegno della teoria di Copernico gli costarono, da parte della Chiesa, l’ammonizione, la condanna e l’umiliazione dell’abiura in ginocchio davanti ai cardinali della Congregazione del Sant’Uffizio. Per quasi 400 anni la posizione della Chiesa nei suoi confronti non è cambiata di molto. Cosa ha fatto Giovanni Paolo II? Innanzitutto il 10 novembre 1979, in un discorso alla Pontificia Accademia delle Scienze dice: “Signor Presidente! Ella nel Suo discorso ha detto giustamente che Galileo e Einstein hanno caratterizzato un’epoca. La grandezza di Galileo è a tutti nota, come quella di Einstein; ma a differenza di questi che oggi onoriamo di fronte al Collegio cardinalizio nel nostro palazzo apostolico, il primo ebbe molto a soffrire – non possiamo nasconderlo – da parte di uomini e organismi di Chiesa. Il Concilio Vaticano II ha riconosciuto e deplorato certi indebiti interventi: “Ci sia concesso di deplorare – è scritto al n. 36 della Costituzione conciliare Gaudium et spes – certi atteggiamenti mentali, che talvolta non mancarono nemmeno tra i cristiani, derivati dal non avere sufficientemente percepito la legittima autonomia della scienza, e che, suscitando contese e controversie, trascinarono molti spiriti a tal punto da ritenere che scienza e fede si oppongano tra loro;. Il riferimento a Galileo è reso esplicito dalla nota aggiunta, che cita il volume Vita e opere di Galileo Galilei di Mons. Paschini, edito dalla Pontificia Accademia delle Scienze.
A ulteriore sviluppo di quella presa di posizione del Concilio, io auspico che teologi, scienziati e storici, animati da uno spirito di sincera collaborazione, approfondiscano l’esame del caso Galileo e, nel leale riconoscimento dei torti, da qualunque parte provengano, rimuovano le diffidenze che quel caso tuttora frappone, nella mente di molti, alla fruttuosa concordia tra scienza e fede, tra Chiesa e mondo. A questo compito, che potrà onorare la verità della fede e della scienza, e dischiudere la porta a future collaborazioni, io assicuro tutto il mio appoggio. Mi sia lecito, Signori, offrire alla loro attenta considerazione e meditata riflessione, alcuni punti che mi appaiono importanti per collocare nella sua vera luce il caso Galileo, nel quale le concordanze tra religione e scienza sono più numerose, e soprattutto più importanti, delle incomprensioni che hanno causato l’aspro e doloroso conflitto che si è trascinato nei secoli successivi. …”
Nel 1981 venne istituita una commissione di studio sul caso Galilei che dopo undici anni propose la sua conclusione: la condanna di Galilei del 1633 fu ingiusta per una indebita ingerenza della Commissione pontificia dell’epoca. Era già un notevole passo verso la verità. Giovanni Paolo II, il 31 ottobre 1992, nel suo discorso alla sessione plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze riprende il caso ed espone le conclusioni della Commissione:“… Ero mosso da simili preoccupazioni, il 10 novembre 1979, in occasione della celebrazione del primo centenario della nascita di Albert Einstein, quando espressi davanti a questa medesima Accademia l’auspicio che “dei teologi, degli scienziati e degli storici, animati da spirito di sincera collaborazione, approfondissero l’esame del caso Galileo e, in un riconoscimento leale dei torti, da qualunque parte essi venissero, facessero scomparire la sfiducia che questo caso ancora oppone, in molti spiriti, a una fruttuosa concordia tra scienza e fede”… Inoltre, la rappresentazione geocentrica del mondo era comunemente accettata nella cultura del tempo come pienamente concorde con l’insegnamento della Bibbia, nella quale alcune espressioni, prese alla lettera, sembravano costituire delle affermazioni di geocentrismo. Il problema che si posero dunque i teologi dell’epoca era quello della compatibilità dell’eliocentrismo e della Scrittura.
Così la scienza nuova, con i suoi metodi e la libertà di ricerca che essi suppongono, obbligava i teologi a interrogarsi sui loro criteri di interpretazione della Scrittura. La maggior parte non seppe farlo.
Paradossalmente, Galileo, sincero credente, si mostrò su questo punto più perspicace dei suoi avversari teologi…. Possiamo già qui formulare una prima conclusione. L’irruzione di una nuova maniera di affrontare lo studio dei fenomeni naturali impone una chiarificazione dell’insieme delle discipline del sapere. Essa le obbliga a delimitare meglio il loro campo proprio, il loro angolo di approccio, i loro metodi, così come l’esatta portata delle loro conclusioni. In altri termini, questa novità obbliga ciascuna delle discipline a prendere una coscienza più rigorosa della propria natura.
Il capovolgimento provocato dal sistema di Copernico ha così richiesto uno sforzo di riflessione epistemologica sulle scienze bibliche, sforzo che doveva portare più tardi frutti abbondanti nei lavori esegetici moderni e che ha trovato nella Costituzione conciliare Dei Verbum una consacrazione e un nuovo impulso. … Se la cultura contemporanea è segnata da una tendenza allo scientismo, l’orizzonte culturale dell’epoca di Galileo era unitario e recava l’impronta di una formazione filosofica particolare. Questo carattere unitario della cultura, che è in sé positivo e auspicabile ancor oggi, fu una delle cause della condanna di Galileo. La maggioranza dei teologi non percepiva la distinzione formale tra la Sacra Scrittura e la sua interpretazione, il che li condusse a trasporre indebitamente nel campo della dottrina della fede una questione di fatto appartenente alla ricerca scientifica. … Galileo, che ha praticamente inventato il metodo sperimentale, aveva compreso, grazie alla sua intuizione di fisico geniale e appoggiandosi a diversi argomenti, perché mai soltanto il sole potesse avere funzione di centro del mondo, così come allora era conosciuto, cioè come sistema planetario…. L’errore dei teologi del tempo, nel sostenere la centralità della terra, fu quello di pensare che la nostra conoscenza della struttura del mondo fisico fosse, in certo qual modo, imposta dal senso letterale della S. Scrittura….” In pratica sono stati riconosciuti gli errori delle gerarchie della Chiesa sul caso Galilei. Per arrivare a riconoscere eventuali errori in altri “casi” famosi, ad esempio quello di Giordano Bruno, forse ci vorranno altri secoli.
Slides su Pisa e Galileo Galilei: http://youtu.be/7BdaaFpakzw
Per leggere l’intero discorso di Papa Giovanni Paolo II:
Chi vuole consultare o scaricare alcune opere originali di Galilei (Sidereus Nuncius, Il Saggiatore, Dialogo sopra i due massimi sistemi, ecc. : http://fermi.imss.fi.it/rd/bd
Una serie di 12 documentari sulla vita di Galilei:
