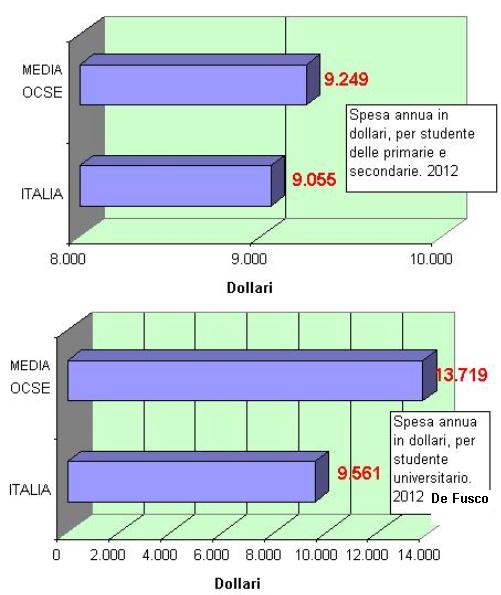Ieri, la ministra dell’istruzione Valeria Fedeli e la presidente della Camera dei deputati Laura Boldrini, hanno presentato al pubblico e agli studenti una “cassetta degli attrezzi” per difendersi dalle bufale della Rete. Un’iniziativa che concorre all’educazione digitale portata avanti dalle scuole per contrastare le menzogne del web ed i pericoli per le persone, giovani soprattutto, ad esse correlati.
Ieri, la ministra dell’istruzione Valeria Fedeli e la presidente della Camera dei deputati Laura Boldrini, hanno presentato al pubblico e agli studenti una “cassetta degli attrezzi” per difendersi dalle bufale della Rete. Un’iniziativa che concorre all’educazione digitale portata avanti dalle scuole per contrastare le menzogne del web ed i pericoli per le persone, giovani soprattutto, ad esse correlati.
Il decalogo proposto comprende solo otto punti di attenzione e riflessione mentre gli altri due sono lasciati alla formulazione degli studenti. Si tratta di concetti che generalmente vengono già segnalati agli studenti nelle scuole, ma proposti ai mezzi di comunicazione da due autorità dello Stato assumono una forza e un rilievo maggiore anche in ambito didattico.
1. condividi solo notizie che hai verificato;
2. Usa gli strumenti internet per verificare le notizie;
3. Chiedi le fonti e le prove;
4. Chiedi aiuto a una persona esperta o a un ente competente;
5. Ricorda che anche internet e i social network sono manipolabili;
6. Riconosci i vari tipi negli stili delle notizie false;
7. Hai un potere enorme, usalo bene;
8. Dai il buon esempio.
Bisogna segnalare e ripetere spesso i potenziali rischi della Rete, dove tutti possono scrivere e caricare di tutto e chiunque abbia scopi illeciti può mascherarsi dietro false identità. La formazione ad un uso consapevole della Rete è fondamentale per conoscerne i rischi, sempre più subdoli, e per sfruttarne appieno invece le enormi potenzialità. Usando le parole di Marshall McLuhan (morto nel 1980, ben prima dell’arrivo di Internet): “Il nuovo ambiente plasmato dalla tecnologia elettrica è un ambiente cannibalistico che divora le persone. Per sopravvivere, bisogna studiare le abitudini dei cannibali.”
Naturalmente si mentiva e si scrivevano falsità anche molto prima dell’avvento di Internet, ma la Rete per le sue dimensioni e per la sua capacità di arrivare a tutti coloro che sono connessi, in qualunque parte del pianeta, in pochi secondi, è uno strumento potentissimo e devastante che può esercitare la sua azione distruttiva soprattutto sui più giovani. Perché ad attirare l’attenzione dei ragazzi sono soprattutto le notizie, i video e le immagini sensazionali, improbabili verità camuffate con pochi clic di mouse. Come un tam-tam d’altri tempi, queste false notizie rimbalzano velocemente da un social network ad un altro, da un continente ad un altro, così “mentre la menzogna gira per il mondo, la verità si sta ancora infilando le scarpe” (Charles Spurgeon, 1834-1892).
La lotta contro le menzogne del web, per la scuola e le famiglie (quando sono presenti) è una lotta impari che però deve necessariamente essere affrontata, almeno per ridurre, attenuare, i loro effetti negativi sulla formazione dei giovani.
Per la presidente Boldrini: “ La Rete è un grande spazio di libertà e non possiamo lasciarla in mano ai violenti e la cosa migliore è formare i nostri giovani a un uso consapevole della rete, a saper riconoscere quello che è vero da quello che è falso perché purtroppo la disinformazione impazza”.Crediti immagine: 2013guccioutlet.net.





 Si è tenuto anche quest’anno, tra fine febbraio e l’inizio di marzo, il convegno “OrvietoScienza”, un incontro di studiosi in cui si affrontano i principali nodi della scienza in relazione alla società e alla scuola. Il tema del convegno del 2014 è stato “Scienza e diritto” ed ha affrontato argomenti di scienze della vita e di biotecnologie, intrecciati con la legislazione italiana.
Si è tenuto anche quest’anno, tra fine febbraio e l’inizio di marzo, il convegno “OrvietoScienza”, un incontro di studiosi in cui si affrontano i principali nodi della scienza in relazione alla società e alla scuola. Il tema del convegno del 2014 è stato “Scienza e diritto” ed ha affrontato argomenti di scienze della vita e di biotecnologie, intrecciati con la legislazione italiana. Maria Chiara Carrozza ha una formazione accademica ingegneristica, come l’ex ministro Profumo, ed è ordinario di Bioingegneria Industriale a Pisa e Rettore della Scuola Superiore Sant’Anna nella stessa città. Ieri, in occasione del passaggio di consegne con il predecessore Francesco Profumo, il Ministro Carrozza ha detto: “E’ una responsabilità importante – riferendosi al suo nuovo incarico – quello che mi preme di più ora è essere all’altezza di questo compito. Mi ha fatto piacere che alla Camera e in Senato ci siano state molte repliche su scuola, ricerca e innovazione, con la specifica richiesta di non abbandonare l’agenda digitale”. La scuola, ma anche la ricerca – ha aggiunto “sono temi trasversali che uniscono il Paese. C’é un’ampia convergenza sul fatto che ricerca e innovazione siano fondamentali per il futuro dell’Italia e questo per il ministero è un buon segnale di avvio”. …
Maria Chiara Carrozza ha una formazione accademica ingegneristica, come l’ex ministro Profumo, ed è ordinario di Bioingegneria Industriale a Pisa e Rettore della Scuola Superiore Sant’Anna nella stessa città. Ieri, in occasione del passaggio di consegne con il predecessore Francesco Profumo, il Ministro Carrozza ha detto: “E’ una responsabilità importante – riferendosi al suo nuovo incarico – quello che mi preme di più ora è essere all’altezza di questo compito. Mi ha fatto piacere che alla Camera e in Senato ci siano state molte repliche su scuola, ricerca e innovazione, con la specifica richiesta di non abbandonare l’agenda digitale”. La scuola, ma anche la ricerca – ha aggiunto “sono temi trasversali che uniscono il Paese. C’é un’ampia convergenza sul fatto che ricerca e innovazione siano fondamentali per il futuro dell’Italia e questo per il ministero è un buon segnale di avvio”. …